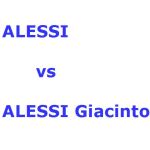MARCHIO NOTORIO contro MARCHIO SIMILE A NOTORIO – Quinta commissione di ricorso 14.07.2016
marchio NORCINERIA FIORUCCI DAL 1850 contro marchio VINI FIORUCCI
La Quinta commissione di ricorso si è espressa rispetto alla complessa vicenda intercorsa tra il noto marchio NORCINERIA FIORUCCI DAL 1850 , storico marchio conosciuto specie nelle regioni di Umbria e Lazio, per la produzione di salumi e insaccati e VINI FIORUCCI, marchio successivamente registrato, il cui ambito principale di applicazione è quello delle bevande alcoliche. Secondo la giurisprudenza, quando un terzo tenta, mediante l’uso di un marchio simile a un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest’ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l’immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in parola. Nel nostro caso il settore della salumeria non trova la sua naturale espansione in quello delle bevande alcoliche e viceversa, e l’azienda che fa capo al marchio notorio non ha presentato nessun argomento convincente per confutare tale conclusione.
Dunque, il pubblico non vincolerà, né stabilirà un nesso tra i due marchi poiché, conscio dell’attuale pratica nel mercato, questo non sarà propenso a ritenere che il marchio notorio, per quanto reputato nel settore della salumeria, abbia deciso di estendere la sua attività al settore delle bevande alcoliche, tenendo altresì conto dell’elevata reputazione e notorietà dei marchi anteriori, visto che esse si riferiscono solo a salumi ed insaccati.
TESTO DELLA DECISIONE
Nel procedimento R 939/2015-5
CESARE FIORUCCI S.p.A.
Viale Cesare Fiorucci, 11
00040 Pomezia (RM)
Italia
Opponente / Ricorrente
rappresentato da BARZANÒ & ZANARDO, via Piemonte, 26, 00187 Roma, Italia
contro
Daniele Fiorucci
Via PIERSANTI N.58
NORCIA (PG)
Italia
Richiedente / Resistente
rappresentato dall’AVV. F. MUSELLA, via Miguel Cervantes de Saavedra n. 64, 80133 Napoli, Italia
RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 248 931 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 11 814 571)
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da G. Humphreys (Presidente e Relatore), A. Pohlmann (Membro) e V. Melgar (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda del 14 maggio 2013, Daniele Fiorucci (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio denominativo
VINI FIORUCCI
per i seguenti prodotti e servizi
Class 33 – Bevande alcoliche (escluse le birre); Acquaviti; Alcool di menta; Alcool di riso; Alcoolici; Amari [liquori]; Anice [liquore]; Anisetta; Aperitivi; Arack; Bevande alcooliche ad eccezione delle birre; Bevande alcooliche contenenti frutta; Bevande alcooliche premiscelate, tranne che a base di birra; Bevande distillate; Cocktails; Curaçao; Digestivi [alcooli e liquori]; Essenze alcooliche; Estratti alcoolici; Estratti di frutta con alcool; Gin [acquavite]; Idromele; Kirsch; Liquori; Nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; Rum; Saké; Sidro; Sidro di pere; Vinello; Vini; Vodka; Whisky.
Classe 43 – Bar-ristoranti; Caffetterie.
2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 18 giugno 2013.
3 In data 16 settembre 2013, CESARE FIORUCCI S.p.A. (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e servizi.
4 L’opponente basava l’opposizione sui seguenti marchi anteriori:
– Marchio dell’Unione europea n. 10 862 878 , depositato il 7 maggio 2012 e registrato il 18 settembre 2012 per i seguenti prodotti:
Classe 29 – Carne, pesce, pollame e selvaggina; Estratti di carne; Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; Gelatine, marmellate, composte; Uova; Latte e prodotti derivati dal latte; Olii e grassi commestibili.
Classe 30 – Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; Riso; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali; Pane, pasticceria e confetteria; Gelati; Zucchero, miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per fare lievitare; Sale; Senape; Aceto, salse (condimenti); Spezie; Ghiaccio.
– Marchio italiano n. 1 097 202 FIORUCCI, depositato il 25 novembre 1974, registrato il 06 gennaio 1979 e rinnovato il 25 febbraio 2008 per prodotti della Classe 29.
– Marchio italiano n. 1 524 975 , depositato in data 8 giugno 2012 e registrato il 9 gennaio 2013 per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 29 – Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.
Classe 30 – Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
5 Con decisione del 16 marzo 2015 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione accoglieva l’opposizione solo per una parte dei prodotti in contestazione e la rigettava per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 33 – Acquaviti; Alcool di menta; Alcool di riso; Alcoolici; Amari [liquori]; Anice [liquore]; Anisetta; Aperitivi; Arack; Bevande alcooliche contenenti frutta; Bevande distillate; Cocktails; Curaçao; Digestivi [alcooli e liquori]; Essenze alcooliche; Estratti alcoolici; Estratti di frutta con alcool; Gin [acquavite]; Idromele; Kirsch; Liquori; Nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; Rum; Saké; Sidro; Sidro di pere; Vodka; Whisky.
Classe 43 – Bar-ristoranti; Caffetterie.
in quanto riteneva che in relazione a detti prodotti e servizi in contestazione non sussistesse rischio di confusione alcuno. In particolare, la
Divisione di Opposizione ravvisava quanto segue:
– L’opposizione basata sul marchio italiano anteriore n. 1 097 202 deve essere respinta in quanto infondata giacché l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione di questo marchio anteriore entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, RMUE. L’esame dell’opposizione inizierà pertanto tenendo in conto il marchio dell’Unione europea anteriore n. 10 862 878.
– I prodotti contestati “vinello e vini e le bevande alcoliche (escluse le birre); bevande alcooliche ad eccezione delle birre; bevande alcooliche premiscelate, tranne che a base di birra” , queste ultime essendo categorie più ampie che comprendono anche prodotti quali i vini, presentano alcuni punti di contatto con l’aceto in Classe 30 dell’opponente. È vero che i prodotti contestati sono bevande alcoliche, mentre l’aceto non contiene alcool e serve per insaporire, condire o conservare i cibi; di qui il diverso metodo d’uso di questi prodotti. Inoltre, questi prodotti hanno normalmente una diversa origine. Tuttavia, la natura di questi prodotti è la medesima, essendo tutti frutto della lavorazione dell’uva. Inoltre, il pubblico rilevante è pure il medesimo. Pertanto, si ritiene che questi prodotti siano simili in basso grado.
– Parte dei prodotti contestati in Classe 33, ossia “acquaviti; alcool di menta; alcool di riso; alcoolici; amari [liquori]; anice [liquore]; anisetta; aperitivi; arak; bevande alcooliche contenenti frutta; bevande distillate; cocktails; curaçao; digestivi [alcooli e liquori]; essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; gin [acquavite]; idromele; kirsch; liquori; nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; rum; sakè; sidro; sidro di pere; vodka; whisky”, questi prodotti non solo hanno diversi produttori, natura e canali di distribuzione rispetto ai prodotti nelle Classi 29 e 30 dell’opponente ma anche un diverso metodo d’uso e una diversa destinazione. Neppure tra di essi presentano alcun grado di concorrenzialità o complementarità. Pertanto, la Divisione di Opposizione li ritiene dissimili.
– I servizi contestati di “bar-ristoranti; caffetterie” comprendono essenzialmente la fornitura di cibi e bevande. Questi servizi sono destinati a servire cibo e bevande direttamente per il consumo. Il semplice fatto che i cibi e le bevande siano consumati in un ristorante non è una ragione sufficiente per individuare una somiglianza tra loro.
– La realtà del mercato dimostra che alcuni produttori di alimenti e/o bevande forniscono anche servizi di ristorazione sotto il loro marchio (ad es. il caffè e le relative caffetterie, il gelato e le relative gelaterie, la birra e i relativi pub); tuttavia questa non è una consuetudine commerciale consolidata e si applica più che altro ad aziende (economicamente) di successo. Queste circostanze debbono essere provate caso per caso. In altre parole debbono essere forniti elementi probatori convincenti che in una determinata realtà, anche nazionale, determinati produttori di cibi e bevande forniscono altresì direttamente servizi di ristorazione tramite il medesimo segno distintivo.
– Nel presente caso la Divisione di Opposizione ritiene che, in assenza di tale prova, non si può non concludere che i suddetti servizi e i prodotti dell’opponente nelle Classi 29 e 30 non presentino caratteristiche tali da permettere di giungere a una conclusione in senso positivo in tema di somiglianza tra di essi. La natura, la destinazione, la modalità d’uso e i canali di distribuzione sono diversi. L’origine abituale, come detto sopra, non è una consuetudine commerciale consolidata. Inoltre, a riguardo, l’opponente non ha fornito argomenti incontrovertibili di sorta. Pertanto, i prodotti e servizi ora oggetto di comparazione sono da ritenersi dissimili.
– Il territorio di riferimento è l’Unione Europea. Per motivi di economia procedurale, la Divisione di Opposizione incentrerà la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.
– Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere “F-I-O-R-U-C-C-I”, per quanto, nel caso del marchio impugnato, con la limitazione dovuta all’uso di caratteri di fantasia. Essi differiscono negli elementi verbali aggiuntivi “NORCINERIA” e “DAL 1850” del marchio anteriore, nella parola “VINI” posta prima di “FIORUCCI” nel caso del marchio impugnato e, ancora per quanto concerne il marchio anteriore, negli elementi figurativi rappresentati dall’ovale di colore marrone e dal fiocco rossoverde.
– Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono il termine “F-I-O-R-U-C-C-I”, comune a entrambi i segni. Entro questi limiti essi sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono delle lettere “N-O-R-C-I-N-E-R-I-A” e “D-A-L”, oltre che nel suono derivante dalla pronuncia del numero “1850”, elementi questi del marchio anteriore e nel suono delle lettere della prima parola “V-I-N-I” del marchio impugnato.
– Sotto il profilo concettuale, il termine “FIORUCCI” che i segni hanno in comune sarà percepito dal pubblico di lingua italiana come un cognome, in special modo diffuso nelle regioni italiane dell’Umbria e del Lazio (vedasi l’informazione fornita a riguardo nella pagina web www.cognomix.it). Entro questi limiti, i segni sono concettualmente simili. Essi differiscono invece per quanto riguarda i rimanenti elementi presenti nei due segni, ossia, nel segno anteriore, la parola “NORCINERIA”, che sarà intesa come il “nome dato un tempo in Roma al locale in cui si macellava, si lavorava e si vendeva la carne di maiale e i prodotti di salumeria, rimasto più a lungo (e vivo ancora oggi) come insegna della bottega di vendita” (si veda la voce del Dizionario Treccani, Edizione online), l’espressione “DAL 1850”, che sarà percepita con il significato di “a partire dall’anno 1850” e, nel segno impugnato, il termine “VINI”, come il plurale della parola ‘VINO’, con il significato di ‘prodotto derivato dalla fermentazione alcolica, completa o parziale, del mosto di uve fresche o lievemente appassite, in presenza o in assenza delle parti solide, il cui titolo alcolico, secondo la regolamentazione vigente, non deve essere inferiore all’8,5% in volume (ad eccezione di alcune zone nelle quali è consentito, per diversità climatologiche e ambientali, un tenore non inferiore al 7%) […] (ibidem).
– Tenuto conto delle coincidenze visive, fonetiche e concettuali, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili.
– Il segno impugnato non ha elementi che potrebbero essere considerati dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.
– L’elemento “VINI” del segno impugnato è associato invariabilmente al concetto di prodotto derivato dalla fermentazione alcolica, completa o parziale, del mosto di uve fresche o lievemente appassite. Tenendo conto che i prodotti rilevanti sono bevande alcoliche, vino e vinello, si considera che questo elemento è privo di capacità distintiva per questi prodotti. La parte del pubblico di riferimento che comprende il significato dell’elemento non presterà la stessa attenzione a tale elemento privo di capacità distintiva che rivolgerà all’altro elemento più distintivo del marchio. Di conseguenza, l’impatto di tale elemento è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in questione. L’elemento “DAL 1850” del marchio anteriore sarà associato alla data di stabilimento dell’attività produttiva e commerciale. Si considera che questo elemento sia dotato di una limitata capacità distintiva, considerando che un’associazione verrà stabilita con la data di inizio dell’attività. La parte del pubblico di riferimento che comprende il significato dei detti elementi non presterà la stessa attenzione a tali elementi di limitata capacità distintiva che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l’impatto di tali elementi di limitata capacità distintiva è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in questione. L’elemento “FIORUCCI” nel marchio anteriore è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. In virtù della sua posizione centrale e delle sue dimensioni, esso fa passare in secondo piano gli altri elementi verbali del marchio.
– Per quanto riguarda il marchio anteriore, va osservato che esso è composto da almeno un elemento verbale distintivo, ossia “FIORUCCI” e da elementi figurativi di natura prettamente decorativa dotati di capacità distintiva minore. È per questa ragione che l’elemento verbale “FIORUCCI” è considerato maggiormente distintivo rispetto agli elementi figurativi.
– Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione.
– Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco che nella fattispecie deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva.
– Nel presente caso, i prodotti che risultano essere simili in basso grado sono diretti al grande pubblico. Il livello di attenzione sarà medio.
– La Divisione di Opposizione ritiene che la parte del pubblico di lingua italiana si riferirà a entrambi i marchi principalmente attraverso il termine “FIORUCCI”, che non solo è visivamente assai simile e foneticamente identico, ma sarà anche associato ad un cognome diffuso specialmente nelle regione dell’Umbria e del Lazio.
– Posto quanto sopra, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio d’interdipendenza a mente del quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti (e viceversa), la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento di lingua italiana per i prodotti reputati identici e simili. Infatti, il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore, data la corrispondenza tra l’elemento dominante del marchio anteriore e l’unico elemento distintivo del marchio impugnato.
– I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta.
– Le stesse considerazioni sono valide anche in relazione al marchio italiano anteriore n. 1 524 975, che protegge prodotti identici a quelli che copre l’altro marchio anteriore considerato.
– In quanto all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, si ritiene che l’opponente non sia stato in grado di dimostrare che il pregiudizio o l’indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. Infatti, l’opponente non ha presentato prove né ha svolto una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.
– Nel caso specifico, la Divisione di Opposizione non può che costatare come, oltre ad affermare la notorietà e a sostenere che i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che si riscontrano fra essi, l’opponente non ha fornito alcun fatto, osservazione o prova, di carattere incontrovertibile, a sostegno della conclusione che l’uso del marchio contro cui viene proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.
– L’opponente non mostrato con dovizia di particolari, l’esistenza di casi reali estrapolati da concrete situazioni di mercato riguardanti una “espansione naturale del settore alimentare”, e quindi, nel caso presente, di un percorso effettivo di un qualsivoglia operatore commerciale che, a partire dal settore della salumeria, sia poi giunto a quello della fornitura di servizi di bar-ristoranti o caffetterie e della produzione di bevande alcoliche.
– L’opponente non ha presentato prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emergesse in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che fosse possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.
– Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Dal momento che l’opponente non è stato in grado di fornire ragioni valide da cui si possa concludere che l’uso del segno impugnato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o recare pregiudizio agli stessi, l’opposizione è considerata infondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
6 In data 14 maggio 2015 l’opponente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l’annullamento nella misura in cui l’opposizione era stata respinta per i prodotti e servizi summenzionati al punto 5 della presente decisione (“i prodotti e servizi oggetto del ricorso”). L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 16 luglio 2015.
7 Nelle sue osservazioni in risposta ricevute dall’Ufficio in data 2 ottobre 2015, la richiedente chiedeva il rigetto del ricorso.
Conclusioni e argomenti delle parti
8 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:
– Si ritiene che la Divisione di Opposizione abbia errato nel considerare che “aceto” coperto dal marchio anteriore non fosse simile ai prodotti oggetto del ricorso.
– In particolare, si reputa che la Divisione di Opposizione sia incorsa in una contraddizione affermando che non esiste somiglianza alcuna tra questi prodotti in conflitto quando, invece, tutti i prodotti oggetto del ricorso rientrano nella categoria di bevande alcoliche, le quali sono state ritenute simili all’“aceto”.
– Inoltre, in termini generali, si considera che esista una certa affinità tra i prodotti oggetto del ricorso e i prodotti delle Classi 29 e 30 poiché sono frequentemente consumati allo stesso tempo ed abbinati tra loro.
– La Divisione di Opposizione è incorsa in errore anche nel ritenere che i servizi oggetti del ricorso non fossero dissimili dai prodotti protetti dal marchio anteriore nella Classe 30.
– Il pubblico è infatti a conoscenza del fatto che produttori di alimenti e/o bevande forniscono anche servizi di ristorazione. Questa è, contrariamente a quanto affermato dalla Divisione di Opposizione, una consuetudine commerciale consolidata nel mercato. Si citano indirizzi di pagine web a sostegno di tale argomento.
– La Divisione di Opposizione avrebbe dovuto riconoscere che i prodotti e servizi in conflitto possono essere offerti dalla medesima impresa.
– Inoltre, non è infrequente che certi esercizi che offrono i servizi di bar e ristorazione offrano altresì la possibilità di ordinare e portare via i prodotti.
– Quindi, dato l’elevato grado di somiglianza tra i segni a raffronto e l’accresciuto carattere distintivo del marchio anteriore, esiste, contrariamente a quanto erroneamente concluso dalla Divisione di Opposizione, un rischio di confusione in relazione ai prodotti e servizi oggetto del ricorso.
– La decisione impugnata è altresì viziata da errore nella misura in cui l’Ufficio si è limitato unicamente a richiamare le argomentazioni presentate dall’opponente, concludendo aprioristicamente che esse non fossero sufficienti per dimostrare quanto richiesto dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
– Infatti, la Divisione id Opposizione avrebbe dovuto tenere conto della circostanza che i marchi anteriori godono di notorietà e prestigio in Italia per salumi insaccati. L’opponente ha investito ingenti somme di denaro per promuovere i suoi prodotti contraddistinti dia marchi anteriori. Infine, la richiedente non ha fornito una giusta causa per usare il marchio impugnato.
– Alla luce di ciò, così come del fatto che i segni sono molto simili e che i prodotti e servizi in conflitto sono quantomeno affini, è altamente probabile che, alla luce delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, si possa produrre vantaggio indebito e/o arrecare un pregiudizio del carattere distintivo di questi marchi anteriori.
9 Gli argomenti presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue:
– I segni, nonostante coincidano nel termine “FIORUCCI”, presentano numerose differenze verbali e grafiche che permettono al pubblico di riferimento di distinguerli come appartenenti a distinte imprese.
– I prodotti e servizi in conflitto non sono simili così come dimostra la loro appartenenza a classi differenti. Inoltre, l’opponente non usa il marchio anteriore per i servizi della Classe 43.
– Dunque, poiché i prodotti e servizi designati dai marchi non sono simili, la Divisione di Opposizione ha concluso correttamente che, nel caso di specie, non sussiste rischio di confusione alcuno in relazione ai servizi oggetto del ricorso.
– In effetti, i prodotti e servizi di cui trattasi non sono complementari tra loro e quindi, anche qualora il marchio godesse di un elevato carattere distintivo, non si presentano le condizioni necessarie per accogliere l’opposizione relativamente ai servizi oggetto del ricorso.
– Inoltre, in quanto all’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, non si comprende quale indebito vantaggio potrebbe mai ottenere il marchio impugnato visto che i marchi in conflitto operano in porzioni di mercato diverse.
– L’opponente è incorsa in un’evidente contraddizione nell’affermare che l’uso del marchio impugnato potrebbe arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. Infatti, l’opponente afferma che quella dei servizi di ristorazione rappresenterebbe un’espansione naturale della sua attività, per poi invece rivendicare che un uso del marchio in relazione ai detti servizi sarebbe pregiudiziale per il carattere distintivo del marchio anteriore. L’attività di ristorazione-bar-caffetteria sarebbe piuttosto un pregio e, in quanto tale, non apporta alcun detrimento alla rinomanza del marchio anteriore.
– È altresì doveroso aggiungere che l’opponente non pe stata in grado di fornire la prova di una concreta modifica del comportamento economico del consumatore di riferimento.
– L’esistenza di un giustificato motivo all’uso del marchio impegnato è dato dal fatto che esso corrisponde al cognome della richiedente.
Motivazione
10 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.
11 Il ricorso è altresì parzialmente fondato e, nello specifico, in relazione ai servizi oggetto del ricorso nella Classe 43.
Questione preliminare
12 In via preliminare, è doveroso osservare che in sede di ricorso l’opponente non ha contestato la conclusione della Divisione di Opposizione che l’opposizione basata sul marchio italiano n. 1 097 202 è da ritenersi infondata. Pertanto, detto diritto anteriore resta escluso dal presente ricorso.
13 Inoltre, dato che la Divisione di Opposizione ha ravvisato che non sussiste un rischio di confusione con riguardo ai prodotti e servizi oggetto del ricorso tenendo prevalentemente in considerazione il marchio dell’Unione europea anteriore n. 1 062 878 (“il marchio anteriore considerato”), questa Commissione inizierà il riesame del caso valutando se il marchio impugnato e questo diritto anteriore su cui si basa l’opposizione possono indurre pubblico di riferimento in un rischio confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE.
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b,) RMUE
14 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
15 Infatti, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.
Pubblico di riferimento
16 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
17 Nel caso in esame il territorio rilevante è costituito dall’Unione europea nel suo complesso e anche dall’Italia, poiché i marchi anteriori che devono essere considerati nella valutazione del rischio di confusione sono una registrazione di marchio dell’Unione europea e una registrazione italiana.
18 Con riguardo al marchio anteriore registrato presso l’Ufficio, occorre ricordare che per rifiutare la registrazione di un marchio dell’UE, è sufficiente che un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE esista in una parte dell’Unione (v. 21/03/2011, T 372/09, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 20 e giurisprudenza ivi citata).
19 Pertanto, la Commissione in principio limiterà la sua valutazione del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE tenendo in conto la percezione della parte del pubblico di lingua italiana.
20 Occorre, altresì, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del pubblico può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. 22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
21 Le parti convengono sul fatto che i prodotti e servizi coperti dai marchi in conflitto sono diretti al grande pubblico, cui consumatore medio si ritiene normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Tale valutazione è confermata dalla Commissione.
Comparazione dei prodotti e servizi
22 Con riguardo al raffronto dei prodotti e servizi di cui trattasi, va ricordato che esso va effettuato tenendo conto di tutti fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i prodotti e servizi in questione. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d’utilizzazione, nonché la loro possibile intercambiabilità o complementarità (v. 29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l’origine dei prodotti e le relative reti di distribuzione e vendita.
23 Come risulta da una giurisprudenza costante, sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa (v. 22/01/2009, T 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57, 58, e giurisprudenza ivi citata).
24 Nel caso di specie i seguenti prodotti e servizi oggetto del ricorso:
Classe 33 – Acquaviti; Alcool di menta; Alcool di riso; Alcoolici; Amari [liquori]; Anice [liquore]; Anisetta; Aperitivi; Arack; Bevande alcooliche contenenti frutta; Bevande distillate; Cocktails; Curaçao; Digestivi [alcooli e liquori]; Essenze alcooliche; Estratti alcoolici; Estratti di frutta con alcool; Gin [acquavite]; Idromele; Kirsch; Liquori; Nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; Rum; Saké; Sidro; Sidro di pere; Vodka; Whisky.
Classe 43 – Bar-ristoranti; Caffetterie.
devono essere raffrontati con i seguenti prodotti protetti dai marchi anteriori:
Classe 29 – Carne, pesce, pollame e selvaggina; Estratti di carne; Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; Gelatine, marmellate, composte; Uova; Latte e prodotti derivati dal latte; Olii e grassi commestibili.
Classe 30 – Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; Riso; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali; Pane, pasticceria e confetteria; Gelati; Zucchero, miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per fare lievitare; Sale; Senape; Aceto, salse (condimenti); Spezie; Ghiaccio.
25 L’opponente afferma essenzialmente che i summenzionati prodotti e servizi a confronto sarebbero simili in quanto, a suo avviso, è possibile che il pubblico di riferimento stabilisca una connessione tra essi. Inoltre, l’opponente argomenta che i prodotti oggetto del ricorso, essendo bevande alcoliche, sono comunque simili all’“aceto”, protetto dai marchi anteriori.
26 La Commissione, anche se riconosce che i prodotti in conflitto di cui sopra possono essere consumati nello stesso momento, non può tuttavia condividere la conclusione allegata dall’opponente circa una loro somiglianza rilevante ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
27 Infatti, tenendo conto dei criteri giurisprudenziali menzionati in precedenza, la Commissione ritiene che i prodotti in questione presentino numerosi aspetti differenti che li rendono dissimili agli occhi del pubblico destinatario.
28 In particolare, la Commissione reputa che la Divisione di Opposizione non sia incorsa in contraddizione alcuna nel non rilevare una similitudine rilevante tra questi prodotti e che abbia fornito valide ragioni a sostegno di questa valutazione.
29 In questo senso, è doveroso notare che nella dicitura “bevande alcoliche” rientrano non solo i prodotti oggetto del ricorso, ma anche i “vini” che, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, presentano alcuni punti di contatto con l’“aceto”. Quindi, poiché la definizione generale appena menzionata contiene anche i “vini”, la Divisione di Opposizione ha lecitamente ritenuto che esiste una somiglianza tra questi ultimi e l’“aceto”. Tale somiglianza, tuttavia, non è apprezzabile con riguardo ai prodotti oggetto di ricorso, i quali sono differenti in natura dai “vini”.
30 Tenuto conto di quanto sopra e visto che la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che per apprezzare una somiglianza rilevante tra i prodotti è necessario che i consumatori ritengano normale che i essi siano commercializzati con il medesimo marchio, il che comporta, di regola, che gran parte dei produttori o dei distributori rispettivi di tali prodotti siano i medesimi (v. 11/07/2007, T 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37), la Commissione conclude che la Divisione di Opposizione ha a ragione ritenuto che questi prodotti in conflitto sono dissimili.
31 In quanto ai servizi oggetto del ricorso, l’opponente allega che, oggigiorno, macellerie e pescherie offrono servizi di ristorazione e che, inoltre, esistono caffetterie in cui è possibile acquistare le proprie miscele di caffè. L’opponente fornisce in supporto di quest’argomento gli indirizzi di alcune pagine web italiane. Si citano, a titolo di esempio, le seguenti:
www.amanowine.it/il-fornello-pronto/;
www.pescheriadaclaudio.it/pescheria-da-claudio-milano/;
www.ristorantepescheriamobydick.it/il-ristorante/ristorante-pescheria;
www.facebook.com/www.lagrigliata.it.
32 Secondo l’opponente, la Divisione di Opposizione avrebbe dovuto riconoscere che i servizi oggetto del ricorso e i prodotti protetti dal marchio anteriore considerato possono essere vincolati alla stessa impresa, o allo stesso gruppo di imprese, e che quindi sono simili come inteso dalla giurisprudenza.
33 La Commissione si trova d’accordo con tale linea di ragionamento che, come si espone in seguito, è confermata dalla recente giurisprudenza del Tribunale.
34 In effetti, anche se i prodotti e servizi di cui sopra non condividono la stessa natura, finalità e metodo d’uso e che quindi, stante questi criteri, non vi sarebbe, in principio, una somiglianza rilevante tra essi (v. 13/04/2011, T 345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 51), essi sono complementari e, pertanto, in certa misura simili.
35 In particolare, i prodotti dell’opponente vengono necessariamente impiegati per servire cibo e bevande con la conseguenza che i prodotti e servizi in questione, al contrario di quanto ribadito dalla richiedente in sede di ricorso, sono complementari. Inoltre, il cibo e le bevande possono essere offerto in vendita negli stessi stabilimenti che servono cibo e bevande. Gli indirizzi di pagine web presentati dall’opponente offrono, in questo senso, evidenti esempi d’intersecazione e di sovrapposizione commerciale tra i settori a cui appartengono detti prodotti e servizi. Ne consegue che i servizi in contestazione presentano un nesso sufficientemente stretto con i prodotti dell’opponente (v. 18/02/2016, T 711/13 and T 716/13, HARRY’S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 59, 13/04/2011, T 345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52 e 15/02/2011, T 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46).
36 Pertanto, il pubblico destinatario potrebbe avere l’impressione che i prodotti e servizi in questione possano avere la medesima origine commerciale (v. 04/11/2003, T 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33). Quindi, la Commissione conclude che nel caso in esame esiste un certo grado di somiglianza, anche se non elevato, tra i prodotti e servizi a confronto (v. 18/02/2016, T 711/13 and T 716/13, HARRY’S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 60).
37 La Commissione considera come irrilevante l’affermazione della richiedente che l’opponente non avrebbe usato, né avrebbe intenzione di usare i marchi anteriori per i servizi che sono in contestazione. Infatti, la richiedente non aveva richiesto la prova dell’uso dei marchi anteriori dell’opponente innanzi alla Divisione di Opposizione e, inoltre, il raffronto dei prodotti e servizi deve tenere in considerazione il loro enunciato come rivendicato nella domanda o nella registrazione del marchio e non le loro reali condizioni di utilizzo o l’intenzione d’uso del titolare (v. 15/02/2011, T 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46, 22/03/2007, T 364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 61 e giurisprudenza ivi citata). È altresì irrilevante che i prodotti e servizi sono rivendicati in differenti classi, giacché secondo la regola 2, paragrafo 4, REMC, la classificazione di Nizza serve esclusivamente a fini amministrativi.
Comparazione dei segni
38 I segni da porre a confronto sono i seguenti:
VINI FIORUCCI
marchio impugnato marchio anteriore
39 In linea con la decisione impugnata, anche la Commissione focalizzerà il raffronto dei marchi in relazione alla percezione dei medesimi da parte del pubblico italiano.
40 Il segno contestato è un marchio puramente denominativo che è composto dalle parole “VINI” e “FIORUCCI”. Il segno dell’opponete è invece un marchio figurativo che include elementi verbali, ovverosia l’espressione “NORCINERIA FIORUCCI DAL 1850”, e grafici, vale a dire la rappresentazione di un ovale di colore marrone scuro che contiene gli elementi verbali e la rappresentazione di un fiocco di colore verde e rosso, coperto in parte dalla figura ovale appena menzionata.
41 Per quanto concerne la presenza nei segni a confronto di elementi maggiormente distintivi e dunque più rilevanti agli occhi del pubblico destinatario, la Commissione nota che entrambi contengano la parola “FIORUCCI”, la quale corrisponde a un cognome italiano che come giustamente puntualizzato dalla Divisione di Opposizione è diffuso prevalentemente nelle regione del Lazio e dell’Umbria.
42 Secondo la giurisprudenza, il consumatore italiano attribuisce, in generale, maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome (v. 28/06/2012, T 134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 45, e giurisprudenza ivi citata).
43 A tale riguardo, la Corte ha precisato che occorre prendere in considerazione, in particolare, la circostanza che il cognome di cui trattasi sia raro o, invece, molto comune, perché essa può influire sul suo carattere distintivo (v. 24/06/2010, C 51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36). Nel caso in esame “FIORUCCI” è, in linea con quanto esposto nella decisione impugnata, un cognome diffuso prevalentemente nelle regioni dell’Umbria e del Lazio. Pertanto, non è possibile ritenere che, in termini generali, il cognome “FIORUCCI” sia estremamente diffuso in tutto il territorio italiano. Quindi, l’elemento in questione possiede un gradiente distintivo in relazione ai prodotti e servizi designati dai marchi.
44 In quanto agli altri elementi dei segni, la Commissione reputa che gli elementi verbali siano descrittivi e dunque deboli, e che gli elementi figurativi abbiano una funzione ornamentale e allo stesso tempo rafforzativa del messaggio convogliato dal segno dell’opponente. In particolare, per ciò che riguarda gli elementi verbali “VINI”, “NORCINERIA” e “DAL 1850”, tutti descrittivi rispettivamente della qualità dei prodotti, dell’origine dei prodotti e della data di fondazione dell’impresa produttrice, la Commissione ricorda che, in genere, il pubblico non considera un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l’elemento distintivo e dominante dell’impressione d’insieme che tale marchio complessivo produce (v. 05/04/2006, T–202/04, Echinaid, EU:T:2006:106, § 54).
45 Per quanto attiene alla componente figurativa del marchio anteriore considerato, giova ricordare che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio (v. 14/07/2005, T–312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289). Inoltre, come anticipato sopra, gli elementi del segno in questione hanno una funzione meramente ornamentale e, secondo questa Commissione, l’impiego del tricolore serve meramente a informare il pubblico destinatario che i prodotti dell’opponente provengono dall’Italia.
46 Alla vista di queste considerazioni, la Commissione ritiene che l’elemento verbale “FIORUCCI” sia l’elemento maggiormente distintivo dei segni.
47 Tenuto in conto di quanto sopra, la commissione trova che sotto il profilo visivo i segni generino impressioni d’insieme simili nella misura in cui entrambi contengono la parola “FIORUCCI”. Questo elemento possiede una certa distintività ed è posizionato nella parte centrale del marchio anteriore considerato. Invece, nel marchio in contestazione, questo elemento è anticipato dalla parola “VINI”.
48 La Commissione nota che i segni presentano varie differenze, che sono state elencate ai punti precedenti. Tuttavia, queste differenze, date basicamente dalla presenza di elementi verbali dispari e di elementi figurativi che sono propri del marchio anteriore, non sono in grado di controbilanciare, e quindi di annullare, una moderata similitudine visiva tra i segni. Infatti, detti elementi o sono deboli, o sono ornamentali.
49 Con riguardo alla circostanza allegata dalla richiedente che la principale differenza tra i rispettivi elementi verbali riguardi la parte iniziale dei medesimi, si ricorda che la regola in base alla quale il consumatore attribuisce maggior importanza alla prima parte di una parola non è applicabile a qualsiasi caso (v. 23/09/2015, T–193/14, AERONAUTICA / NAUTICA et al., EU:T:2015:668, § 24, e giurisprudenza citata). Nel caso di specie, gli elementi verbali iniziali dei segni sono caratterizzati da una connotazione descrittiva e pertanto, il loro impatto sarà limitato.
50 Ne consegue che i segni devono essere ritenuti moderatamente simili dal punto di vista visivo.
51 Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono nel suono fatto dalla pronuncia della parola “FIORUCCI”. I segni invece differiscono foneticamente nella misura in cui la parola “VINI” sarà pronunciata per prima nel marchio impugnato, mentre, in quello anteriore, saranno pronunciate le parole “NORCINERIA”, per prima, e “DAL 1850”, per ultima.
52 Quindi, fatta eccezione per la parola “FIORUCCI”, i segni presentano elementi verbali dispari, così com’è dispari il numero di sillabe. Ciò nonostante, è stato giudicato che il fatto che il numero di sillabe sia differente, non basta per scartare la sussistenza di una somiglianza fonetica fra i segni (v. 19/05/2011, T–580/08, Pepequillo, EU:T:2011:227, § 79, e giurisprudenza ivi citata), che nel caso di specie è data dalla presenza in entrambi dell’elemento verbale “FIORUCCI”.
53 La Commissione riconosce che il suono iniziale dato dalla pronuncia degli elementi verbali dei segni è differente (“VINI” vs. “NORCINERIA”). Ciononostante, occorre ricordare ancora una volta che, secondo la giurisprudenza, se è pur vero che la parte iniziale dei marchi potrebbe catturare maggiormente l’attenzione del consumatore rispetto alle parti seguenti, tale considerazione non può valere in tutti i casi (v. 28/06/2012, T–134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 57). Nella fattispecie, come precedentemente osservato, presso la parte del pubblico di lingua italiana le espressioni “VINI” e “NORCINERIA” sono carenti di capacità distintiva per i prodotti e servizi coperti dai marchi.
54 Concettualmente, i segni presentano una somiglianza nei limiti che entrambi fanno riferimento al cognome “FIORUCCI”, suggerendo pertanto che si tratti di persone tra le quali intercorrono rapporti di parentela (v., per analogia, 28/06/2012, T–134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 60).
55 Dunque, in entrambi i casi, l’origine commerciale dei prodotti e servizi contraddistinti dai marchi in conflitto sarà percepita dal consumatore di riferimento come legata ad una persona che porta tale cognome. Di conseguenza, in tale misura, i due marchi sono simili dal punto di vista concettuale (per analogia, v. 28/06/2012, T–133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327 e 28/06/2012, T–134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 60).
56 I segni differiscono nei restanti concetti convogliati dai loro elementi dispari. Ciononostante, questi elementi non sono sufficienti da distogliere l’attenzione del consumatore dall’elemento comune “FIORUCCI” in base al quale il pubblico stabilirà un nesso concettuale tra i segni.
57 Pertanto, secondo questa Commissione, non può essere scartata una certa somiglianza concettuale tra i segni.
58 Alla luce di tutte queste considerazioni, la Commissione ritiene che i segni, valutati nel loro complesso, siano simili.
Valutazione globale del rischio di confusione
59 L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Occorre altresì ricordare che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (v. sentenza “Sabèl”, citata, punto 24), e viceversa.
60 Nel caso di specie, la richiedete non ha contestato l’affermazione che i marchi anteriori godono di una certa fama e reputazione presso i consumatori in Italia per prodotti quali salumi ed insaccati. Tale circostanza è d’altronde dimostrata dalla documentazione depositata dall’opponente (rassegna stampa relativa agli anni 2010-2013, l’attività di sponsorizzazione nel calcio in Italia, i dati relativi alla quota di mercato detenuta, ecc.). Pertanto, la Commissione ritiene che per questi prodotti il marchio anteriore considerato sia altamente distintivo e che, per i restanti prodotti, esso sia intrinsecamente distintivo in un grado normale.
61 Nel presente caseo, è stato confermato che i segni, considerati nel loro complesso, sono simili. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla Divisione di Opposizione, è stato stabilito che alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale, effettivamente, esiste un’affinità rilevante tra i servizi oggetto del ricorso e i prodotti dell’opponente.
62 Per queste ragioni, è corretto ritenere che l’uso del marchio in contestazione per servizi affini e complementari ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore considerato è in grado di generare confusione, o quanto meno associazione, tra le attività del richiedente e quelle dell’opponente. L’identità dell’elemento, sicuramente distintivo, “FIORUCCI” sorprenderà inevitabilmente il consumatore italiano e lo indurrà a ritenere, erroneamente, che entrambe le diciture fanno capo allo stesso imprenditore o ad imprese collegate.
63 Conseguentemente, occorre concludere che per il pubblico italiano dell’Unione europea esiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE relativamente ai servizi oggetto del ricorso.
64 Invece, detto rischio non è ravvisabile per i prodotti oggetto del ricorso che, come visto sopra, sono dissimili da quelli dell’opponente.
65 Infatti, la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria perché il motivo di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE possa trovare applicazione, anche quando il marchio anteriore è altamente distintivo e/o quando i segni sono identici (07/05/2009, T 185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 54; 19/11/2008, T 6/07, Nanolat, EU:T:2008:515, § 49; 11/11/2009, T 162/08, Green by missako, EU:T:2009:432, § 51-54; 14/10/2009, T 140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 53, 61 as confirmed by 24/03/2011, C 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-68; 23/01/2014, C 558/12 P, Western Gold, :EU:C:2014:22, § 50).
66 Poiché l’opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE risulta essere fondata solo per i servizi oggetto del ricorso, la Commissione è tenuta ad esaminare se, in relazione ai prodotti oggetto del ricorso, le condizioni necessarie per ammettere l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono soddisfatte.
Articolo 8, paragrafo 5, RMUE
67 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, a seguito dell’opposizione del titolare di una marchio anteriore, la registrazione di una domanda di marchio impugnata è denegata se il marchio della Unione europea e il marchio anteriore sono identici o simili e se il marchio della Unione europea è registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione europea o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
68 Tale norma permette che un marchio possa beneficiare di una tutela ampliata a prodotti e servizi non simili, qualora l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
69 La tutela estesa accordata dall’articolo 8, paragrafo 5, del RMUE presuppone il ricorrere di varie condizioni. “In primo luogo, il marchio anteriore che si pretende notorio dev’essere registrato. In secondo luogo, tale marchio e il marchio dell’Unione europea di cui si richiede la dichiarazione di nullità devono essere identici o simili. In terzo luogo, il marchio anteriore deve godere di notorietà nell’Unione europea, ove si tratti di un marchio dell’Unione europea anteriore, o nello Stato membro interessato, nel caso di un marchio nazionale anteriore. In quarto luogo, l’uso del marchio dell’Unione europea impugnato senza giusto motivo deve condurre al rischio che sia tratto indebitamente un vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che sia arrecato un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore.
70 Poiché tali condizioni sono cumulative, la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la disposizione in questione” (v. 07/12/2010, T 59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 28).
71 La Commissione osserva che le argomentazioni dell’opponente sono principalmente volte a dimostrare come l’uso senza giusta causa del marchio impugnato per i servizi oggetto del ricorso (“bar e ristoranti”) possa costituire un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo dei marchi anteriori.
72 Non sono state tuttavia presentate valide argomentazioni volte a far ritenere che l’uso del marchio impugnato per le bevande alcoliche oggetto del ricorso possa rappresentare un vantaggio indebito o possa arrecare un danno alla reputazione dei marchi anteriori che, come visto sopra, si riferisce ad insaccati e salumi.
73 A tale riguardo, la Commissione conferma le valutazioni effettuate dalla Divisione di Opposizione circa l’assenza di una linea di argomentazione coerente e convincente da parte dell’opponente per dimostrare l’esistenza di un percorso effettivo, anche di un qualsivoglia operatore commerciale, che, a partire dal settore della salumeria, sia poi giunto a quello della produzione bevande alcoliche di alta gradazione.
74 In questo senso, la Commissione reputa che la distanza tra i prodotti in conflitto e soprattutto l’attuale pratica nel mercato non permettano di concludere che possa verificarsi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori. Conseguentemente, è doveroso concludere che il pubblico di riferimento non sarà in grado di stabilire un nesso tra ai marchi.
75 Infatti, l’esistenza di un nesso deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 18/06/2009, C 487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 45). Tra questi fattori è possibile annoverare: il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto; la natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato; il livello di notorietà del marchio anteriore; la distintività, intrinseca o acquisita grazie all’uso, del marchio anteriore; l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico (v. 27/11/2008, C 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).
76 Quando un terzo tenta, mediante l’uso di un marchio simile a un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest’ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l’immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in parola (v., per analogia, 18/06/2009, C 487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 45).
77 Orbene, nella fattispecie i prodotti per cui i marchi anteriori sono notori e le bevande alcoliche, tra cui non rientrano prodotti vinicoli e birre, della richiedente non sono fabbricati dalle stesse imprese. Ancor più importante, il settore della salumeria non trova la sua naturale espansione in quello delle bevande alcoliche e viceversa, e l’opponente non ha presentato nessun argomento convincente per confutare tale conclusione.
78 Dunque, il pubblico non vincolerà, né stabilirà un nesso tra i due marchi poiché, conscio dell’attuale pratica nel mercato, questo non sarà propenso a ritenere che l’opponente, per quanto reputato nel settore della salumeria, abbia deciso di estendere la sua attività al settore delle bevande alcoliche e, più in particolare, a quello dei prodotti oggetto del ricorso, il quale si tratta di un settore assai specifico.
79 Tale situazione non si produrrà nemmeno tenendo conto dell’elevata reputazione e notorietà dei marchi anteriori, visto che esse si riferiscono solo a salumi ed insaccati.
80 Infine, l’opponente non ha fornito ragioni per cui l’immagine di qualità associata ai suoi marchi dovrebbe trasferirsi al marchio impugnato per i prodotti in oggetto del ricorso.
81 Quindi, nonostante la reputazione e notorietà dei marchi anteriori, si deve concludere che l’opponente non sia stato in grado di stabilire che, nel caso di specie, vi siano i presupposti necessari per considerare prima facie, anche mediante deduzioni logiche, che l’uso del marchio impugnato per bevande alcoliche di altra gradazione come sono i prodotti oggetto del ricorso possa rappresentare una situazione di vantaggio indebito della reputazione e della notorietà dei marchi anteriori per insaccati e salumi. Nemmeno la presenza di un grado medio di somiglianza tra i segni può inficiare questa conclusione.
82 Inoltre, ad avviso di questa Commissione, l’uso del marchio impugnato per i prodotti oggetto del ricorso non è nemmeno suscettibile di arrecare un pregiudizio alla reputazione dei marchi anteriori.
83 A tale riguardo si deve rammentare che, relativamente al pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, detto anche “annacquamento” o “degradazione”, tale pregiudizio si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un’influenza negativa sull’immagine del marchio (v. 18/06/2009, C 487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 40).
84 Tuttavia, tale situazione non si verificherà nella fattispecie. Infatti, la giurisprudenza ha stabilito che le bevande alcoliche non sono per sé dannose per la salute, ma che solo un loro consumo eccessivo può provocare effetti negativi per l’essere umano. Pertanto, i prodotti alcolici non conferiscono nessuna connotazione negativa che contrasti con l’immagine di alta qualità che secondo l’opponente il pubblico di riferimento associa con i marchi anteriori (v., per analogia, 29/10/2015, T 517/13, “QUO VADIS” / QUO VADIS, EU:T:2015:816, § 43).
85 Alla luce di tutte queste ragioni, la Commissione conclude che il pubblico di riferimento non stabilirà un nesso tra i marchi in relazione ai prodotti in conflitto e che, inoltre, le argomentazioni dell’opponente non sono in grado di dimostrare che l’uso del marchio impugnato per i prodotti oggetto del ricorso è suscettibile di dar luogo ad un vantaggio indebito della notorietà dei marchi anteriori o di arrecare pregiudizio a tale notorietà.
86 Pertanto, non è necessario esaminare le altre condizioni cumulative stabilite dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
87 Ne consegue che l’opposizione non può essere accolta sulla base del motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
Conclusione
88 L’opposizione deve essere accolta nella misura in cui esiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE per i servizi oggetto del ricorso. L’opposizione è deve essere rigettata per il resto.
Spese
89 Ai sensi dell’articolo 85(2), paragrafo 2, RMUE, per motivi di equità, ciascuna parte sopporterà le proprie spese nell’ambito del procedimento di opposizione e nel procedimento di ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:
1. Il ricorso è accolto in parte.
2. La decisione impugnata è annullata nella misura in cui l’opposizione è stata rigettata per i servizi oggetto del ricorso.